Esploriamo una serie di tradizioni religiose popolari e usanze legate al ciclo agricolo e alle festività cristiane di Contrada Lucchetta (VI). Verranno descritte particolari celebrazioni come la Candelora, San Biagio e la festa di San Martino, evidenziandone riti, proverbi e leggende. Inoltre si discuterà dell”importanza relativa alle celebrazioni religiose nel passato, il ruolo della Chiesa nella vita quotidiana e come alcune pratiche e il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale siano cambiate nel tempo. Un caso su tutti: il battesimo. Segue uno spezzone d’intervista.
Il 2 febbraio si celebrava la Candelora. Durante questa celebrazione si benedivano le candele che venivano accese in caso di tempesta per proteggere i raccolti. Il detto popolare recitava “la candelora, dall’inverno semo fora”.
Il 3 febbraio – San Biagio – si benedivano le mele. Noi ricordiamo però che le mele venivano benedette durante la messa il giorno di San Biagio e poi portate a casa dalle nonne per essere condivise col resto delle famiglie. Il 5 febbraio poi era il giorno di Sant’Agata. A Valdagno si piantava l’insalata mentre a Castelgomberto si piantava nel giorno di Santa Apollonia, il 23 giugno festa di San Giovanni. Quest’ultima era abbastanza bizzarra, era il solstizio d’estate, era usanza spezzare un rametto di geranio fiorito, schiacciare un’estremità, legarlo su un palo con piccolo ramo di salice e tenerlo lì per il lungo periodo. Il rametto di geranio non appassiva e anzi rifioriva nel periodo successivo. Si strappava poi qualche piuma nella coda dei merli perché così si diceva che le penne rispuntassero più forte di prima.
Il primo giorno di Quaresima, il mercoledì dei ceneri era tradizione mangiare di magro. Il piatto popolare era ovi e germoi, uova bollite e germogli di radicchio. L’ascensione o giorno dell’assenza cadeva 40 giorni dopo la Pasqua. Legate a questa festività ci sono le ciliege. Una particolare varietà tipica di questo periodo è caratterizzata da un colore chiaro, non tutta rossa. Era usanza anche mangiare la bondola, una specie di salame con dentro una lingua di vitello, mi pare.
Il 29 giugno, festa di San Pietro, si faceva la barca di San Pietro ottenuta ponendo in una bottiglia alta e larga – piena d’acqua – nell’orto, sotto alle foglie di zucchine. Si faceva quindi cadere un albume nell’acqua e non si metteva il coperchio. Il mattino seguente il freddo, la rugiada e qualche reazione davano vita a un piccolo miracolo. Dentro la bottiglia si vedeva una specie di veliero con vele spiegate.
Il 7 ottobre poi la Madonna del Rosario: era a tradizione di mangiare bigoli con l’arna (anatra). L’11 novembre festa di San Martino. San Martino è patrono di numerose città e paesi. Più o meno tutti conoscono San Martino. La sua storia è di un uomo generoso che con la spada fece due pezzi del suo mantello e ne diede una metà ad un povero perché potesse ripararsi dal freddo. Dopo il gesto di bontà si racconta che il tempo freddo e piovoso si trasformò in una giornata calda e soleggiata, fenomeno da cui deriva l’espressione “l’estate di San Martino” per indicare le giornate insolitamente calde di novembre. Intorno all’11 novembre si festeggiava anche la fine della vendemmia e si iniziava a bere vino novello come testimoniato da questi proverbi.
A San Martin cascan le foglie e si spina il buon vin e – ancora – da San Martin el mosto diventa vin.
San Martino è anche il patrono degli osti. La leggenda dice che trasformò l’acqua in vino. Somiglia tanto al Signore.
Anche il modo di dire in dialetto “Far San Martin” si riferisce al periodo intorno all’11 novembre. Nelle aree agricole fino a non molti anni fa tutti i contratti di lavoro, ma anche di Mezzadria, eccetera, avevano inizio e fine l’11 novembre – la data scelta – in quanto i lavori dei campi erano già terminati senza però che fosse già arrivato all’inverno. Per questo scaduti i contratti, chi aveva una casa in uso la doveva lasciare libera proprio l’11 di novembre e non era inusuale in quei giorni imbattersi in carri strapieni di cose che si trasportavano da un podere all’altro, facendo appunto San Martin. Nome popolare, proprio per questo motivo, del trasloco.
Grandi e piccoli recitavano le preghiere al mattino e alla sera. Il tempo per le preghiere si trovava sempre perché ai fedeli veniva inculcato che mancare le preghiere era peccato. Seppur venale, ma sempre peccato. Nelle camere di ogni sposa timorata di Dio trovava spazio anche l’acquasantiera e gli sposi al mattino e alla sera facevano il segno della croce intingendo le dita nell’acqua santa prima di recitare le preghiere.
Con l’avvicinarsi del periodo pasquale arrivava la domenica delle palme. La festa era un tripudio di rami d’ulivo con fiori di carta crespa sventolati dai bambini e delle bambine lungo la processione che giungeva fino alla chiesa per la celebrazione della messa solenne. Le palme venivano tagliate e i ramoscelli tenuti nelle case a protezione delle famiglie, ma in particolare venivano bruciati quando sulla zona si abbattevano forti temporali o grandinate. Alle finestre si poneva un piccolo recipiente contenente piccole braci sulle quali si lasciava bruciare qualche foglietta secca di olivo e venivano pronunciate le preghiere precedute dall’invocazione “dal furore e dalle tempeste liberaci o Signore”.
Anche accendere le candele benedette era un modo per far calmare il temporale. Dopo la domenica delle palme iniziavano le 40 ore di adorazione. Ogni contrada aveva il suo turno per l’adorazione del Santissimo che rimaneva esposto in chiesa dalla domenica sera al martedì. Il giovedì santo si teneva la lavanda di piedi. Il venerdì santo la solenne processione con la statua di Gesù disteso, portata a braccio dagli uomini intorno alle vie della chiesa. I bambini suonavano le raccole: strumenti particolari che emettevano un rumore gracchiante. Per la processione del venerdì santo a Valdagno veniva chiamata la banda Marzotto ad accompagnare il baldacchino e i fedeli. I bar spegnevano le luci e accendevano dei lumini. Per la settimana santa, tutte le statue di crocifissi all’interno della delle chiese venivano coperte con drappi viola che venivano tolti soltanto la sera del sabato santo durante la celebrazione della messa. Il sabato le campane stavano in silenzio tutto il giorno e solo dopo la messa serale con la benedizione del fuoco, ricominciavano i loro rintocchi.
Non ti resta che ascoltare l’intervista!
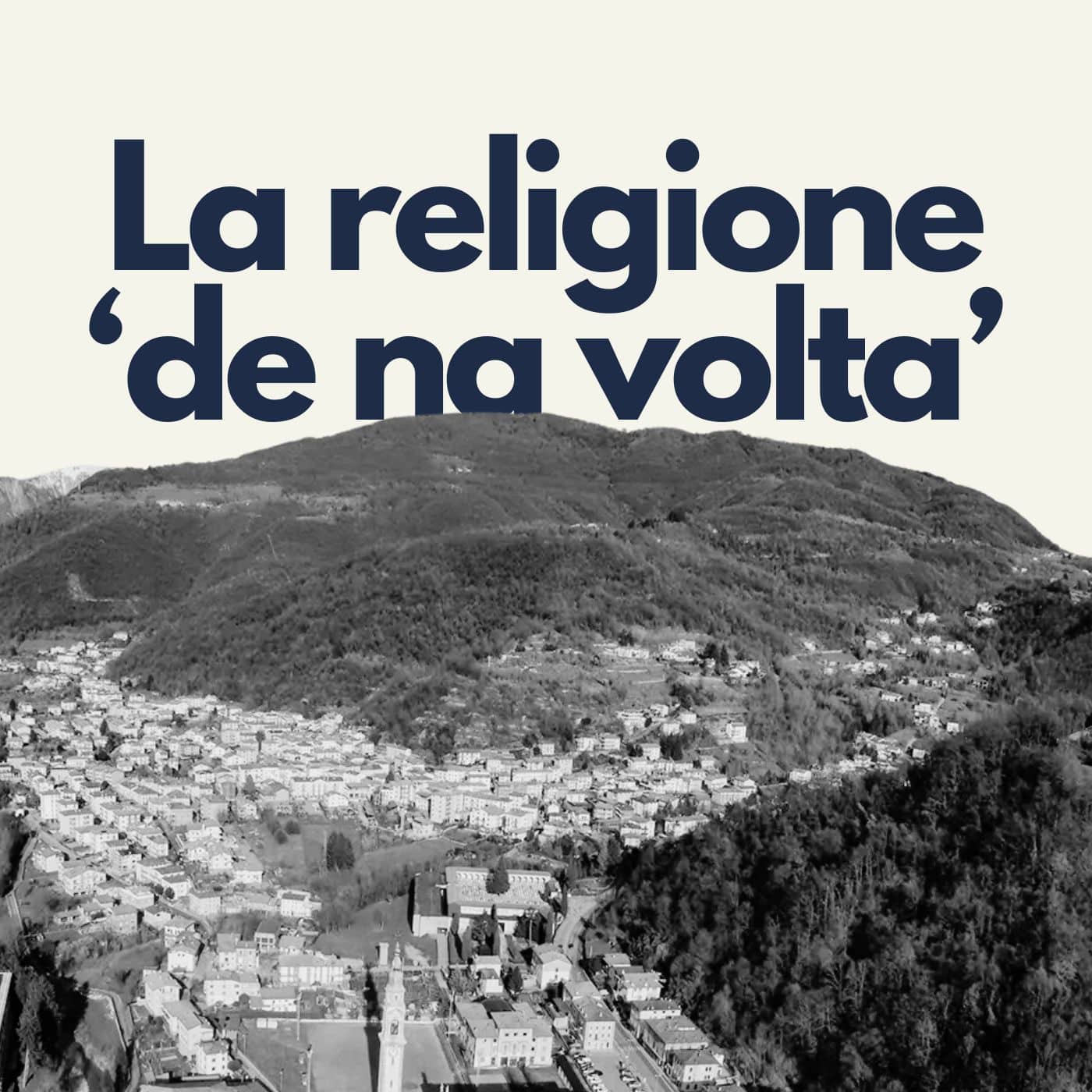
Lascia un commento